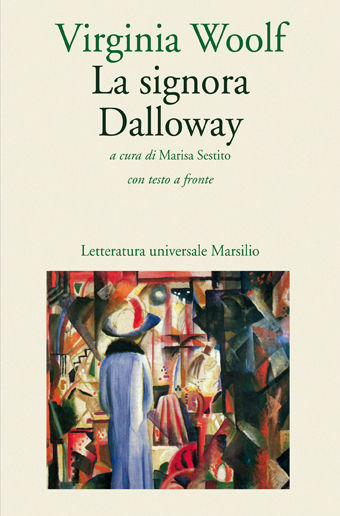Dopo l'audace sperimentazione de La stanza di Jacob, nel 1925 Virginia Woolf approda a La signora Dalloway, il suo primo grande romanzo, per molti il più bello. A ridosso dell'Ulisse di Joyce (che Virginia non amava, ma con il quale inevitabilmente intreccia un dialogo a distanza), ancora un racconto concentrato su un unico giorno (un mercoledì di giugno 1923), e un unico spazio, Londra: una fantasmagoria di strade, sguardi, prospettive e personaggi che si intrecciano e si toccano per poi perdersi e disperdersi nella splendida e lacerante forza vitale della grande città modernista. A contenere questa materia frammentaria e sfuggente sta un uso magistrale di tempo e spazio, marcati da segnali ricorrenti (il suono del Big Ben, il canto degli uccelli, il volo dell'aereo sul quale convergono gli sguardi) e, sul piano della storia, la festa - il ricevimento che Clarissa Dalloway sta preparando per quella calda sera di giugno. Ma è soprattutto la splendida Clarissa - cinquantenne, alto-borghese, una vita apparentemente dorata e un passato di desideri segreti e negati - il punto di attrazione di questa «pioggia di atomi» (come si esprime Virginia Woolf in un famoso saggio) che attorno a lei e alla sua festa si aggrega e si trova per poi perdersi di nuovo. Clarissa e il suo "doppio" sconosciuto, Septimus Warren Smith - giovane, povero, reduce allucinato di una guerra che gli ha sconvolto per sempre la mente e la vita: due esistenze che si intrecciano e si rispecchiano senza mai incontrarsi, lontane eppure accomunate dal dolore e dalla paura, della morte e della vita. Dolore e paura di cui si libereranno, alla fine, con scelte opposte - la morte per Septimus e l'accettazione della vita per Clarissa - che chiudono il viaggio della coscienza di entrambi e i mille percorsi di quella lunga giornata londinese.